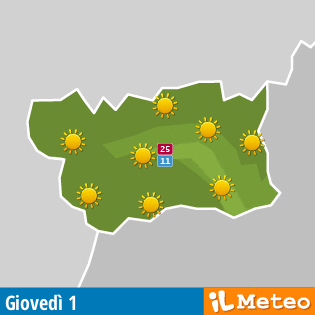Nobel 2025 e l’innovazione come driver di crescita: sfide e priorità
Roma, 31 ott. – «L’assegnazione del Premio Nobel per l’Economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt per aver dimostrato come l’innovazione guidi la crescita economica rappresenta un riconoscimento di portata storica che trascende il perimetro della teoria e investe direttamente le sfide del nostro tempo». Lo scrive Andrea Poggi, Head of Public Policy & Stakeholder Relations Centre e Innovation Leader di Deloitte Central Mediterranean, nel suo articolo pubblicato su Voices.
«Mokyr ha evidenziato che la crescita moderna nasce dall’incontro tra “prescriptive knowledge” – il sapere pratico del “come fare” – e “propositional knowledge”, la comprensione scientifica del “perché”. Aghion e Howitt hanno invece sviluppato un modello in cui l’innovazione diventa una variabile endogena al sistema economico, descrivendo un equilibrio dinamico alimentato dalla competizione e da incentivi istituzionali», scrive Poggi.
Al centro degli studi dei tre economisti si colloca il concetto di “creative destruction”, la dinamica per cui nuove tecnologie, modelli organizzativi e strutture produttive sostituiscono progressivamente quelle esistenti, generando cicli di rinnovamento e progresso economico. «È senza alcun dubbio uno straordinario riconoscimento di portata rilevante, e con impatti sicuramente significativi», commenta l’autore. «Questo arriva in un momento storico in cui l’innovazione rappresenta uno dei principali temi strategici globali, come dimostrato dalla crescente attenzione delle istituzioni europee – dal Green Deal al Rapporto Draghi sulla competitività europea – e dalle agende di sviluppo nazionali e multilaterali».
«È fondamentale ricordare che l’innovazione, come intesa anche dagli studiosi, non è solo tecnologia, e non è solo nuove soluzioni organizzative e nuovi processi, ma è anche cambiamento sociale, istituzionale e culturale, che non si esaurisce nella digitalizzazione o nell’adozione dell’AI, ma riguarda la capacità di costruire sistemi economici resilienti, inclusivi e sostenibili», sottolinea Poggi. «Partendo dal valore di tali studi, la realtà economico-sociale evidenzia come il processo di innovazione, per essere realmente trasformativo, deve essere governato in modo sistemico e cooperativo».
«L’innovazione può generare benefici enormi solo se inserita all’interno di un sistema di regole, scelte etiche e politiche pubbliche capaci di orientarla verso il bene collettivo. Il vero tema diventa comprendere come rendere tutto ciò reale ed efficace. A tal fine, è necessario declinare l’innovazione in priorità operative concrete. Partendo da un’analisi di dati ed evidenze empiriche, e sulla base dell’esperienza di oggi, è fondamentale agire su tre direttrici d’intervento essenziali: accelerare la transizione digitale, colmare il divario di competenze, non solo tecnologiche, e promuovere un’innovazione inclusiva e che abbia una dimensione sociale», spiega Poggi.
Come si evidenzia nell’articolo, sul fronte digitale, i dati evidenziano che le aziende digitalmente più mature mostrano margini superiori del 6%, mentre un aumento del 10% nella “digital adoption” si traduce in un +1,6% del Pil pro capite. Tuttavia, secondo l’UNESCO, 2,6 miliardi di persone nel mondo non hanno ancora accesso a Internet – con la conseguenza che, in assenza di infrastrutture e competenze digitali diffuse, il potenziale dell’innovazione resti in gran parte inespresso.
«Ridurre il divario digitale tra Nord e Sud del mondo, attraverso trasferimento tecnologico, investimenti in infrastrutture e cooperazione internazionale, non è solo una responsabilità etica, ma una condizione necessaria per un progresso globale equilibrato», scrive Poggi. «Il divario di competenze rappresenta oggi la principale barriera ad una crescita che sia pienamente espressa e davvero sostenibile. La trasformazione del lavoro entro il 2030 impone un’azione immediata: quasi il 40% delle attuali competenze diventerà obsoleto e si stima che circa sei lavoratori su dieci avranno bisogno di riqualificazione per rimanere competitivi sul mercato».
«Nuove partnership tra pubblico e privato diventano cruciali per formare le nuove figure professionali rilevanti nei processi di innovazione. È essenziale agire a livello di sistema, sapendo che l’innovazione deve essere antropocentrica: porre la tecnologia al servizio dell’uomo, valorizzare il capitale umano e generare opportunità accessibili a tutti».
«La terza dimensione strategica riguarda l’inclusività dell’innovazione stessa, che non deve polarizzare, ma moltiplicare le opportunità per tutti, generando chiari benefici non solo economici, ma anche sociali, e avviando circoli virtuosi tra economia e società. Le economie democratiche più mature hanno la responsabilità di diffondere tutti gli elementi dell’innovazione oltre le aree già sviluppate, raggiungendo le filiere più piccole, i territori meno connessi, i Paesi emergenti e le categorie ancora escluse», dice Poggi.
Il potenziale, del resto, sembrerebbe, enorme: colmare per esempio i gap di partecipazione femminile nelle economie in via di sviluppo potrebbe aumentare il Pil reale del 22-23%, una cifra che rispecchia sia l’impatto economico che la portata dell’esclusione attuale. «Queste tre priorità, tuttavia, possono tradursi in impatto reale solo se vengono rispettate due condizioni abilitanti all’innovazione che emergono come prerequisiti essenziali», avverte l’autore.
«La prima è assicurare una vera governance strategica dell’innovazione: una pianificazione che integri le capacità e le responsabilità di attori pubblici e privati, orientando gli investimenti, le politiche industriali e le scelte tecnologiche verso obiettivi condivisi e misurabili. Solo attraverso un disegno istituzionale coerente è possibile trasformare l’innovazione in leva di coesione e progresso collettivo», prosegue Poggi.
«La seconda condizione è adottare un approccio di sistema, che includa attivamente business, istituzioni, mondo accademico e società civile. Le sfide superano le capacità di intervento dei singoli attori e richiedono meccanismi di collaborazione strutturati. Occorrono piattaforme permanenti di confronto su azioni congiunte, che favoriscano, tra i diversi attori del sistema socio-economico, la co-progettazione di soluzioni, la condivisione di risorse e conoscenze, l’integrazione tra incentivi pubblici e investimenti privati».
«Tradurre le priorità proposte in risposte concrete è dunque una sfida nella sfida dell’innovazione, e ognuno deve dare il suo contributo. Deloitte promuovendo l’innovazione come volano di crescita economica e sociale, è al servizio del dialogo e della collaborazione tra diversi stakeholder. Questo impegno si traduce stabilmente nell’offrire soluzioni per le imprese, ma anche contenuti e piattaforme di confronto, dove istituzioni, imprese, università e società civile lavorano sinergicamente per identificare soluzioni concrete necessarie per attuare un’innovazione orientata non solo alla crescita economica, ma anche ad un impatto misurabile per il progresso sociale. Come ricorda il concetto di “creative destruction”, l’innovazione può rendere obsoleto solo ciò che non evolve. La vera sfida è essere proattivi e porre in campo azioni per realizzare sistemi economici e sociali interconnessi: dove la crescita dell’uno sostiene la crescita dell’altro, e capaci di rigenerarsi, trasformando la distruzione in opportunità di rinnovamento condiviso», conclude l’Head of Public Policy & Stakeholder Relations Centre e Innovation Leader di Deloitte Central Mediterranean nel suo intervento.