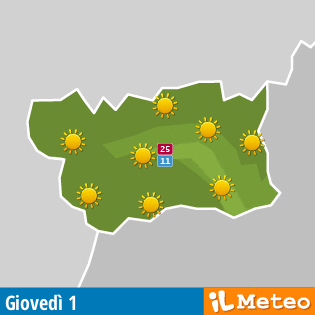La foto del giorno della Nasa è del valdostano d’adozione Alessandro Cipolat Bares
Lo scatto è stato scelto per oggi, 9 luglio 2025
La foto del giorno della Nasa è del valdostano d’adozione Alessandro Cipolat Bares.
La foto del giorno della Nasa è di un astrofotografo aostano.
Lo scatto scelto dalla Nasa come Astronomy Picture of the Day di oggi, 9 luglio 2025, è di Alessandro Cipolat Bares.
La foto del giorno della Nasa
L’astrofotografia è un’arte che richiede pazienza, tecnica e cieli incontaminati.
E a volte, anche un viaggio dall’altra parte del mondo. Lo sa bene Alessandro Cipolat Bares, astrofotografo valdostano d’adozione, che per immortalare la Nebulosa Trifida si è spinto fino in Namibia, sotto uno dei cieli più puri del pianeta.
Il risultato è un’immagine di una bellezza rara, tanto da essere scelta dalla NASA come Astronomy Picture of the Day (APOD) il 9 luglio 2025.
Un riconoscimento che replica quello precedente di due anni fa, con un’immagine della costellazione della Corona Australe, e del 2019, con la Grande Nube di Magellano.
Uno spettacolare laboratorio celeste
La sua Trifida è il racconto di un oggetto celeste a 5.000 anni luce da noi, nel cuore della nostra galassia, la Via Lattea, in direzione della costellazione del Sagittario.
Il 2025 è un anno speciale per APOD, perché festeggia 30 anni di attività.
Definita dalla stessa NASA uno “studio cosmico sui contrasti”, la nebulosa è un unico, spettacolare laboratorio celeste.
L’immagine di Cipolat Bares cattura la complessa natura di questo oggetto.
La nebulosa a emissione, che brilla del rosso acceso tipico degli atomi di idrogeno; quella a riflessione, che risplende di un blu delicato grazie alla luce di stelle riflessa dalle polveri; e le dense nubi scure, fasce di gas freddo che sembrano disegnarne i contorni.
È la regione a emissione rossa, approssimativamente divisa in tre parti da bande di polvere oscuranti, che conferisce alla Trifida il suo nome popolare.
Con un’età stimata di appena 300.000 anni, la nebulosa è la più giovane zona di formazione stellare conosciuta, un luogo dove l’universo è in pieno processo di creazione.
Le parole di Alessandro Cipolat Bares
Dalla Namibia alle piazzole dell’Osservatorio Astronomico di Saint-Barthélemy, che utilizza abitualmente, la ricerca dello scatto perfetto per Alessandro Cipolat Bares non si ferma.
Quali strumenti ha utilizzato per catturare la Nebulosa Trifida?
«Mi trovavo in una “Astrofarm” in Namibia, una struttura dedicata proprio all’astrofotografia, dove il proprietario noleggia diversi osservatori. Per questo scatto ho usato un telescopio rifrattore da 15 cm di diametro, abbinato a un sensore a colori CMOS raffreddato per ridurre al minimo il “rumore” digitale e ottenere un’immagine più pulita».
Perché ha scelto proprio la Namibia per questo scatto? Quali vantaggi offre rispetto ai cieli italiani?
Alessandro Cipolat Bares
«Innanzitutto, la Namibia ha uno dei cieli più bui del pianeta e l’assenza di inquinamento luminoso è un fattore essenziale per immagini come questa.
Inoltre, trovarsi nell’emisfero australe permette di fotografare oggetti celesti, come quelli al centro della Via Lattea, quando sono allo zenit, cioè nel punto più alto del cielo. Dalle nostre latitudini, invece, questi stessi oggetti appaiono molto più bassi sull’orizzonte, immersi nella foschia e nelle luci».
Si potrebbe pensare che un viaggio del genere comporti notevoli difficoltà. Com’è stata, invece, l’esperienza dal punto di vista climatico e logistico?
«Il periodo ideale per fotografare nel deserto del Kalahari va da aprile a settembre, durante l’inverno australe. Le notti sono lunghe, perfettamente secche e serene, senza umidità: le condizioni ideali per l’astrofotografia.
Anche il viaggio è stato agevole: un volo diretto da Francoforte mi ha portato in Namibia, e in poche ore di auto ho raggiunto l’Astrofarm, situata a circa 200 chilometri dalla capitale Windhoek».
Quanto tempo richiede, in media, la realizzazione di un’immagine del “cielo profondo” (deep-sky) come quella della Trifida?
«La Nebulosa Trifida è un oggetto relativamente luminoso, quindi il tempo di acquisizione è stato abbastanza contenuto. Ho realizzato una serie di scatti da 5 o 6 minuti ciascuno, per un totale di circa un’ora e mezzo di posa. Successivamente, queste singole immagini vengono allineate e sommate tramite software specifici. Per oggetti più deboli, tuttavia, possono essere necessarie anche diverse notti di lavoro».
I consigli di Alessandro Cipolat Bares
Che consiglio darebbe a chi vuole iniziare con l’astrofotografia del deep-sky dalla montagna?
«Suggerisco di partire con un’attrezzatura semplice, dedicata alla fotografia a largo campo. Un buon cavalletto stabile, una buona fotocamera e un obiettivo luminoso, come un 24 o un 50 mm.
Già così si possono ottenere ottime immagini della Via Lattea con pose di pochi secondi. Bisogna ricordare che il lavoro si divide tra il tempo passato sul campo a scattare e quello al computer per elaborare le immagini con software dedicati. Infine, la scelta del luogo è cruciale. In Valle d’Aosta abbiamo la fortuna di avere zone molto buie.
Saint-Barthélemy è eccellente per gli oggetti del cielo nord, mentre una valle come quella di Rhêmes è perfetta per puntare a sud, senza essere disturbati dall’inquinamento luminoso di Aosta».
In che modo la Valle d’Aosta, e in particolare Saint-Barthélemy, ha influenzato il suo modo di fare astrofotografia?
«Il mio approccio si è dovuto adattare al cambiamento del cielo. Quando ho iniziato, negli anni Novanta, bastava addentrarsi in Valle d’Aosta per trovare un cielo buio. Negli ultimi 15 anni, però, l’inquinamento luminoso è aumentato notevolmente in tutto il Nord Italia. Di conseguenza, oggi è indispensabile scegliere con ancora più cura i punti di ripresa, cercando i luoghi più bui in assoluto, e spesso si è costretti a utilizzare filtri specifici, che aiutano a isolare le deboli emissioni delle nebulose attenuando la luce artificiale».
Il percorso di Alessandro Cipolat Bares
Il valdostano ripercorre poi il suo percorso.
«Mi appassiona l’astrofotografia da trent’anni. Ho iniziato negli anni ’80 con la fotografia analogica, quando si lavorava con pellicole e camere a sviluppo, e ogni scatto richiedeva pazienza e precisione. Con il tempo sono passato ai sensori digitali, seguendo l’evoluzione della tecnologia fino agli attuali CMOS; strumenti sempre più sofisticati e specializzati. Da dodici anni vivo in Valle d’Aosta. Prima abitavo a Milano, ma già allora cercavo il buio e la quiete delle montagne, salendo spesso nell’Oltrepò pavese e sugli Appennini».
Il percorso
E ancora. «Alla fine sono arrivato in Valle, dove ho trovato scenari d’alta quota perfetti per osservare il cielo.
Silenziosi, limpidi e straordinariamente bui. Frequento regolarmente l’Osservatorio astronomico di Saint-Barthélémy, un punto di riferimento per chi ama il cielo, ma esploro anche luoghi meno noti della regione, sempre alla ricerca della notte perfetta. Qui, nelle sere d’estate, si può ancora ammirare la Via Lattea con chiarezza impressionante.
La passione per il cielo non si ferma all’emisfero boreale; quando posso, osservo anche le meraviglie del cielo australe. Alcune delle mie riprese sono state pubblicate nei libri della serie Gateway To The Sky, curata da Paolo Calcidese, in In viaggio tra le stelle, sempre di Calcidese, e in Passeggiando nel cielo valdostano, con testi di Luciana Caneparo».
(Paolo Ciambi)