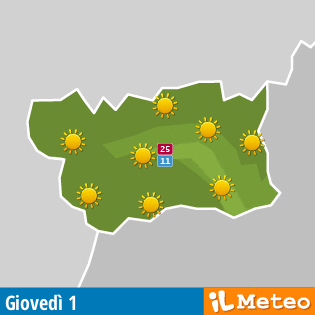Il problema di Italia e Ue con i Paesi che non rispettano i diritti
Roma, 3 mag. (askanews) – Italia e Turchia si sono “impegnate a sostenere i tre pilastri del sistema delle Nazioni Unite, ovvero pace e sicurezza, sviluppo e diritti umani”. Questa frase, sottolineata espressamente da Palazzo Chigi, è l’unico passaggio in cui si cita il tema dei diritti nella dichiarazione congiunta rilasciata dai due Paesi al termine del vertice intergovernativo Italia-Turchia che si è tenuto a Roma martedì 29 aprile. Né del tema si è parlato nell’incontro con la stampa (senza domande) della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente Recep Tayyip Erdogan. Non un accenno, per dirne una, alla vicenda dell’arresto di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e principale avversario di Erdogan alle prossime elezioni presidenziali, e di decine di esponenti di rilievo vicini all’opposizione, tra cui il famoso giornalista televisivo Ismail Saymaz. “Non lo posso più guardare in faccia, ha trasformato la Turchia in una dittatura nell’indifferenza di tutti”, confidava un cittadino turco ormai espatriato in Italia a margine del business forum. Certo, tutti comprendiamo la ragion di Stato di dialogare con un attore strategico per posizione geografica, rapporti economici, peso politico. Ma come ebbe modo di dire Mario Draghi l’8 aprile 2021, “con i dittatori bisogna cooperare ma essere franchi”. Certo il problema di un rapporto con Erdogan troppo addomesticato non è solo italiano. Basti ricordare che l’Unione europea dal 2016 ha erogato ad Ankara 5,7 miliardi di euro per la “gestione” dei migranti. Secondo Emma Sinclair di Human Rights Watch, “l’Unione Europea subappalta le violazioni dei diritti umani a Paesi terzi. È cosciente di stare finanziando un sistema di abusi, e nonostante gli allarmi lanciati dai dipendenti i dirigenti decidono di chiudere un occhio”. Altra l’opinione di Meloni, secondo cui la “cooperazione in ambito migratorio ha funzionato molto bene” con un “sostanziale azzeramento delle partenze dalle coste turche”. Tante che ora, nella dichiarazione, si ipotizza la possibilità di considerare “un approccio che prenda in considerazione soluzioni innovative”.
Altro caso che riguarda da vicino sia l’Italia che l’Europa è quello della Tunisia dove sabato 19 aprile un tribunale ha condannato 40 persone a pene detentive che vanno dai 13 ai 66 anni di carcere per “complotto contro la sicurezza dello Stato”. Sulla lista dei condannati – come ricorda David Carretta sul Mattinale – al termine di un processo definito “un processo farsa di massa” da Amnesty International, ci sono politici dell’opposizione, giornalisti, membri della società civile in Tunisia. Perfino il filosofo francese Bernard-Henri Levy. Nessuna parola, da Roma come da Bruxelles, contro il regime del presidente Kais Saied e la sua deriva autoritaria, timide reazioni sono arrivate da Francia e Germania. Del resto pochi giorni fa l’Ue ha proposto di inserire la Tunisia nella lista dei paesi considerati “sicuri” per i rimpatri. E come dimenticare l’accordo sottoscritto, su impulso di Meloni, nel luglio 2023 a Tunisi da Ursula von der Leyen. Un’intesa con cui l’Ue aveva versato 105 milioni di aiuti immediati per la gestione delle migrazioni e 150 milioni di sostegno diretto al bilancio tunisino e promesso un aiuto macrofinanziario da 900 milioni di euro. La Commissione aveva promesso di rivedere i meccanismi dell’accordo sulla base del rispetto dei diritti umani, ma al momento niente di tutto ciò è accaduto.
Del resto l’Ue un problema, bello grosso, c’è l’ha anche all’interno: quel Viktor Orban che tra modifiche costituzionali per vietare i Pride, bavaglio ai media (il caso più eclatante la scomparsa ormai nel 2016 del quotidiano Nepszabadsag), liste di proscrizione più o meno ufficiali sta minando lo Stato di diritto in Ungheria. Al momento la Commissione ha bloccato circa 18 miliardi di euro, tra sovvenzioni e prestiti, che oggi Budapest non può utilizzare a causa delle violazioni. Ci sarebbe poi la possibilità di utilizzare l’articolo 7 del Trattato sul rischio di violazione grave, da parte di uno Stato membro, dei valori dell’Unione. Un’arma che, però, al momento si esita ad usare. Forse nella speranza che la situazione si risolva per via democratica alle elezioni previste per l’inizio del 2026: Orban e il suo partito Fidesz sono dati, dai sondaggi, in grande difficoltà mentre è in crescita il partito di opposizione Tisza del fuoriuscito Peter Magyar.
Di Alberto Ferrarese e Lorenzo Consoli