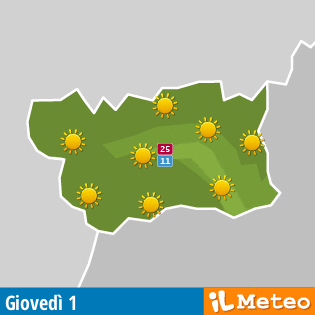Ue, “ReArm Europe”: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
Roma, 3 mag. (askanews) – Come sta andando l’iniziativa per il sostanziale rafforzamento della capacità di difesa degli Stati membri dell’Ue? L’obiettivo del piano ‘ReArm Europe’ (un nome infelice, per cui la Commissione è stata molto criticata, e che ormai non viene più usato) era quello di arrivare a circa 800 miliari di nuovi investimenti nel settore attraverso la due iniziative proposte da Ursula von der Leyen: l’attivazione delle clausole nazionali di sospensione del Patto di stabilità (con un potenziale di spesa stimato a circa 650 miliardi di euro da parte degli Stati membri, entro il 2028) e il prestito comunitario da 150 miliardi di euro (programma ‘Safe’) a cui i paesi che lo vorranno potranno attingere, possibilmente per acquisti congiunti di forniture militari.
Ad oggi, il bicchiere è mezzo pieno, o mezzo vuoto, a seconda dei punti di vista. L’inizio di maggio era la prima tappa per una verifica del successo della prima iniziativa, perché la Commissione aveva fissato informalmente il 30 aprile come scadenza per raccogliere le richieste di attivazione della clausola nazionale di sospensione del Patto di stabilità da parte degli Stati membri, in modo da avere un mese di tempo per valutarle, e sottoporle poi al Consiglio Ecofin, che avrà a sua volta un altro mese di tempo (quindi entro inizio luglio) per dare la sua approvazione finale. L’attivazione della clausola nazionale di sospensione è una novità prevista dal Patto di stabilità riformato, entrato in vigore nel 2024 (prima c’era solo la possibilità di attivare la clausola di sospensione generale, come è stato fatto durante la pandemia di Covid e nel periodo successivo). Ai paesi che la richiederanno, consentirà di aumentare, a partire da quest’anno e fino al 2028, il margine di bilancio da dedicare alle spese per la difesa senza incorrere nelle procedure Ue per deficit eccessivo. Questo aumento consentito del deficit potrà arrivare fino all’1,5% del Pil del paese interessato (calcolato sulla base dei dati del 2021), per ognuno dei quattro anni previsti. Dopo il 2028, comunque, gli Stati membri che avranno utilizzato la clausola di sospensione dovranno cominciare un percorso di aggiustamento per ridurre gradualmente il deficit aggiuntivo e tornare nei parametri del Patto di stabilità. Per ora siamo a 13 paesi che hanno chiesto formalmente l’attivazione della clausola: la prima è stata, lunedì 28 aprile, la Germania, seguita poi martedì 29 da Grecia e Lettonia. Mercoledì 30 aprile, al mattino, sono arrivate le richieste di Estonia e Polonia, quindi dell’Ungheria, e poi, entro la serata, si sono uniti altri sei Stati membri: Belgio, Danimarca, Finlandia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. Venerdì 2 maggio la Commissione ha riferito di aver ricevuto ancora un’altra richiesta, dalla Lituania. Ma il Consiglio Ue ha comunicato già il 30 aprile una lista di 16 paesi, includendo anche quelli che, pur non avendo notificato la richiesta formale, hanno comunque espresso l’intenzione di farlo al più presto. I tre Stati membri aggiuntivi sono la Bulgaria, la Repubblica ceca e la Croazia.
Qui c’è il bicchiere mezzo pieno. Venerdì 2 maggio, a un giornalista che chiedeva se definirebbe l’iniziativa un successo, il portavoce per per l’Economia e il Bilancio della Commissione, Balazs Ujvari, ha risposto: ‘Assolutamente. Si tratta essenzialmente della metà degli Stati membri. E’ un numero significativo, e abbiamo indicazioni che questo numero aumenterà ulteriormente nel prossimo futuro. E questo dimostra che la nostra analisi è condivisa in tutta l’Ue e che la proposta che abbiamo presentato a marzo trova l’interesse degli Stati membri’.’Il fatto è – ha continuato il portavoce – che dobbiamo affrontare sfide e difficoltà straordinarie nel campo della sicurezza a causa dell’attuale situazione geopolitica, e ovviamente dell’aggressione russa in Ucraina. Ed è per questo che è importante aumentare significativamente la nostra spesa per la difesa. L’attivazione della clausola nazionale di sospensione svolgerà un ruolo importante in questo senso’.
Sempre venerdì, durante il briefing quotidiano della Commissione per la stampa, Ujvari ha anche ricordato le tre condizioni che gli Stati membri dovranno rispettare, e che la Commissione dovrà verificare entro il mese di maggio, per il via libera all’attivazione della clausola: ‘Sono le condizioni che esamineremo nelle prossime settimane: da un lato – ha spiegato il portavoce -, devono verificarsi circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro in questione. Inoltre, queste circostanze eccezionali devono avere un impatto sulle finanze pubbliche degli Stati membri interessati. Infine, la deviazione di bilancio ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale non può compromettere la sostenibilità di bilancio a medio termine. (…) Naturalmente, se un paese interessato da una procedura per i disavanzi eccessivi ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, e l’ha ottenuta dal Consiglio Ue, ne terremo conto nella nostra valutazione’. ‘Ricordiamo – ha continuato Ujvari – che questa è la prima volta che viene effettivamente attivata la clausola di salvaguardia nazionale. È uno strumento nuovo. È entrato in vigore con la riforma del Patto di stabilità e crescita nell’aprile 2024, e ora la stiamo applicando in modo coordinato. Quando abbiamo proposto l’idea a marzo, abbiamo affermato che, secondo la nostra analisi, a causa delle problematiche di sicurezza che stiamo affrontando collettivamente come Unione europea, ritenevamo che ci fossero i presupposti perché qualsiasi Stato membro possa trarre beneficio da questa clausola’. ‘Esamineremo le richieste degli Stati membri, in base ai tre criteri’ ricordati in precedenza. ‘Ma non è un segreto il fatto che, a priori, riteniamo che ci siano buone ragioni per approvare le richieste. Le nostre conclusioni arriveranno a inizio giugno, nel contesto del pacchetto di primavera’. ‘L’attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale a nostro avviso – ha spiegato ancora il portavoce – potrebbe sbloccare circa 650 miliardi di euro di spesa aggiuntiva per la difesa. È importante ricordare che si tratta di una cifra approssimativa, ipotetica’. Quando la proposta è stata presentata, ‘ovviamente non sapevamo quanti Stati membri avrebbero effettivamente attivato la clausola e volevamo fornire un ammontare, un ordine di grandezza del margine di bilancio che poteva essere reso disponibile da questa misura. Ma ovviamente al momento non è possibile aggiornare questa cifra in modo affidabile perché, da un lato, non sappiamo quanti paesi alla fine presenteranno la richiesta’. E d’altra parte ‘non sappiamo a quale ritmo aumenteranno le loro spese per la difesa. L’unica cosa che conosciamo sono i parametri stabiliti dalla clausola di salvaguardia nazionale: l’opportunità di discostarsi dal piano strutturale di bilancio a medio termine e di aumentare la spesa per la difesa di un equivalente dell’1,5% del Pil ogni anno tra il 2025 e il 2028, rispetto al 2021’.
Inoltre, ha aggiunto Ujvari, ‘gli Stati membri che non hanno attivato o non vogliono attivare la clausola di salvaguardia nazionale, possono comunque aumentare anche loro la propria spesa per la difesa. Le due cose non sono necessariamente correlate. Attivando la clausola di salvaguardia nazionale, possiamo garantire maggiore flessibilità, ma non è un obbligo, ovviamente. Non avevamo aspettative scolpite nella roccia. Quando presentiamo una proposta, lo facciamo perché pensiamo che susciterà un interesse significativo, e credo che abbia già generato un interesse significativo. C’è la metà degli Stati membri e il numero è destinato a crescere ulteriormente’.
A questo punto un giornalista ha fatto notare che, in effetti, la Commissione un’aspettativa chiara l’aveva creata, ventilando la cifra di 650 miliardi di euro, e di 800 miliardi se si conta anche il programma ‘Safe’, come hanno riportato ampiamente tutti i media. Ora, tra questi 13 paesi, mancano quattro dei cinque Stati membri con il Pil maggiore nell’Ue: Francia, Italia, Spagna e Olanda. La domanda è: sarebbe ancora possibile, senza questi quattro paesi, raggiungere i 650 miliardi di euro nei prossimi quattro anni, e considerare ancora un successo l’iniziativa? E qui c’è il bicchiere mezzo vuoto. ‘L’idea di questo meccanismo – ha replicato la portavoce capo della Commissione, Paula Pinho – era quella di offrire agli Stati membri flessibilità in termini di aumento della spesa per la difesa. Alcuni hanno già un buon livello di spesa per la difesa e potrebbero non aver bisogno di una maggiore flessibilità per farlo. Dovremmo anche esaminare nel dettaglio quanto ogni Stato membro sia interessato ad aumentare la spesa per la difesa, anche per avere un quadro più completo. Ora, per il momento, in termini di adesione al meccanismo, possiamo già affermare che è confermato l’interesse da parte degli Stati membri, dal momento che più della metà dei Ventisette ne ha fatto richiesta. Da questo punto di vista, è un successo. Dovremo vedere quali saranno i prossimi passi e le decisioni finali. Ma – ha insistito Pinho – in termini di interesse, in termini di volontà di cogliere l’occasione e di utilizzare questo nuovo strumento, è ormai chiaro che la situazione è positiva’.
Se si guarda ai numeri (dati del 2023), è chiaro che c’è un problema di una spesa per la difesa ancora lontana dal ‘vecchio’ obiettivo minimo del 2% fissato dalla Nato soprattutto per tre dei quattro grandi paesi assenti dalla lista: l’Italia è ancora all’1,6% del Pil (35,5 miliardi di dollari), mentre la Spagna e l’Olanda sono entrambe all’1,5% del Pil (con rispettivamente 23,7 miliardi e 16,6 miliardi di dollari). La Francia, invece, è al 2,1% del Pil, con 61,3 miliardi di dollari. A una domanda su Italia e Spagna, in particolare, Paula Pinho ha risposto: ‘Vediamo come andrà a finire e se questi due paesi potrebbero unirsi agli altri che hanno fatto richiesta. Non è ancora escluso’.
Quanto al nuovo strumento finanziario ‘Safe’ (‘Security Action for Europe’) da 150 miliardi di euro, è decisamente troppo presto per valutare se sarà un successo o no. Balazs Ujvari ha ricordato che ‘la proposta è al momento sul tavolo del Consiglio Ue. Quindi dovremo aspettare la sua approvazione, e poi gli Stati membri hanno sei mesi di tempo per richiedere un prestito’.
I fondi del ‘Safe’, raccolti dalla Commissione sul mercato, saranno destinati a prestiti per i paesi che li chiederanno, sempre allo scopo di sviluppare le capacità di difesa. Il meccanismo è molto simile a quello del fondo ‘Sure’ da 100 miliardi di euro, usato con successo per sostenere i sistemi nazionali di cassa integrazione e salvare posti di lavoro durante e dopo la pandemia di Covid. Come per il fondo ‘Sure’, i prestiti dovranno essere restituiti a scadenza (di lungo termine) dai paesi che li chiederanno.
In questo caso, è già scontato che una parte dei paesi membri (Germania, Olanda, paesi nordici) non ha alcun interesse a chiedere prestiti all’Ue che avrebbero un tasso d’interesse maggiore di quello che possono scontare loro stessi sui mercati con i propri titoli di Stato. Ma per una ventina circa di Stati membri (compresa l’Italia) i tassi d’interesse applicati agli eurobond emessi dalla Commissione (e garantiti dal bilancio comunitario) sarebbero invece inferiori a quelli delle proprie emissioni di debito nazionali. Il problema qui potrebbe essere quello del cosiddetto ‘stigma’, la reazione negativa dei mercati che i paesi più indebitati, come l’Italia e la Spagna, temono potrebbe derivare dalla richiesta di questi prestiti, come a suo tempo avvenne per i fondi del Mes, il ‘fondo salva-Stati’, a cui l’Italia non volle fare ricorso durante la crisi dell’Eurozona di 15 anni fa.
Di Lorenzo Consoli e Alberto Ferrarese