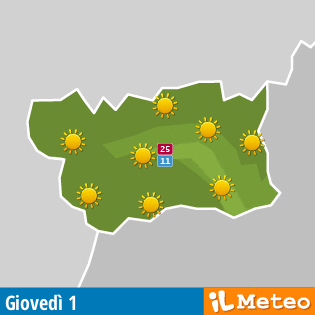Roger Junet, velista valdostano, si racconta allo Splendor
Di Sarre, ma residente negli Stati Uniti, Roger Junet ha portato a termine la Globe 40, la regata in barca vela intorno al mondo, giovedì 4 maggio alle 18 racconterà la sua esperienza al Teatro Splendor
Roger Junet, skipper e velista oceanico ha recentemente portato a termine, al quarto posto, la Globe 40, la regata in barca a vela attorno al mondo.
Insieme a lui, su Gryphon Solo2 lo skipper statunitense Joe Harris.
Il valdostano di Sarre racconterà la sua impresa domani, giovedì 4 maggio, alle 18, al Teatro Splendor nella serata organizzata dall’assessorato allo sport e turismo.
Alla serata, trasmessa in live streaming da valledaostasport.it interverrà l’assessore allo sport e turismo, Giulio Grosjacques.
Ingresso libero.
Pubblichiamo qui di seguito la lunga intervista di Enrico Formento Dojot al velista valdostano, uscita sul numero dell’8 aprile di Gazzetta Matin.
L’intervista
Roger Junet
Una vita sempre in bilico sulla cresta dell’onda, su quel sottile e delicato crinale che separa il farsi trascinare dal dominarla.
Nella seconda parte del crinale si trova prevalentemente Roger Junet, valdostano classe 1984, residente negli Stati Uniti, reduce dalla prima edizione della Globe 40, la prestigiosa regata intorno al mondo a bordo della barca a vela, lui e il suo collega skipper.
E basta.
A dire la verità, mi sarei aspettato un uomo chiuso, una sorta di gabbiano infelice che solca i mari alle prese con tempeste e difficoltà di ogni genere per gestire, stemperare dubbi esistenziali, vincere demoni che gli tolgono il senso della vita.
O, perlomeno, un poeta con insicuri addentellati alla realtà.
Niente di tutto questo.
Roger è un animale sociale, pieno di vita e di progetti, che si gode appieno le sue conquiste, mentre sta già prendendo forma nella sua mente la prossima avventura. Narra con autentica passione le sue esperienze, ma con un fondo di pragmatismo non scontato.
A soli 38 anni ha già vissuto almeno tre vite, e si prepara con entusiasmo a inseguire la quarta o la quinta.
Un’esistenza fin qui vissuta appieno, quasi mangiata, con un grande avvenire dietro le spalle, come tra poco si rivelerà.
Un tuffo nel passato da Montan a Londra
Roger, un tuffo nel passato.
«Sono nato ad Aosta, la mia origine è Montan. Scuola Cerlogne e poi Istituto Alberghiero. I miei avevano un albergo a Saint-Nicolas. Lavoravo e studiavo, posso dire di avere scoperto solo ora le nostre meravigliose montagne».
La sirena viene da Londra.
«In un ristorante francese top in seno ad Harrods. La brigata veniva dagli Champs Elysées. Avevo 21 anni, eravamo aperti sette giorni su sette. Vengo promosso due volte, da commis a demi-chef a chef. Ricordo anche un periodo alla “Vecchia Aosta”».
Il feeling con la capitale inglese si esaurisce presto.
Cominciava a non piacermi più il clima, parlavo male l’inglese essendo alle prime armi, l’impegno richiesto era massacrante. A me piace la natura e volevo esplorare».
L’Australia
Il velista a Cape Horn
Dove meglio che in Australia?
«Conosco in un pub due australiani, appunto. Mi riferiscono che a Sidney cercano cuochi, pagano bene e che mi aspettano sole, caldo e mare. Dopo una settimana sono già dall’altra parte del mondo. Mi ritrovo nel pub più grande d’Australia, una terrazza mozzafiato sul mare, novecento pasti al giorno. Mi occupavo della griglia».
Anche Sidney, però, le sta stretta.
«Sono a Cairns in vacanza per le immersioni in una stupenda barriera corallina. La nave deputata cerca uno chef. Dico “Sidney, c’è un problema” e rimango sulla nave come chef».
A quel punto, la sua vita professionale conosce una svolta.
«Tempo due mesi e divento “Dive Master”, istruttore subacqueo. Purtroppo, a causa di un grave incidente, scadono i termini per la residenza permanente in Australia».
Messico e America del Nord
Altra svolta.
«Vengo a sapere che in Messico c’era un’opportunità per speleologo subacqueo e ci vado, unendo l’attività come free lance di immersioni. Ma un infortunio mi blocca ancora».
E le tocca l’America del Nord.
«Portland, nel Maine. Vendo prodotti finanziari, ma, soprattutto, inizio ad appassionarmi alla vela. Una passione già in embrione in Australia, per la verità. La baia di Portland è stupenda, con maree da dieci piedi, scogli, isole, isolette, balene, foche. Ricordava il Canada, per i pini e gli abeti, che non ti aspetteresti al mare. Con molti equipaggi viaggio tra Bermude, Florida e Canada. Mi dedico alla vela d’altura transoceanica e vinco l’ARC +, una prova attraverso l’Oceano Atlantico con una squadra australiana. E porto un Volvo 70, un tempo la barca a vela più veloce del mondo, dalle Bermude a Capri. Intanto affianco alla vela l’attività di consulente tecnico-assicurativo in tema di uragani».
Cosa le dà la vela, fino a spingerla a imprese estreme e rischiose?
«Il senso dell’avventura, innanzitutto. Parti dall’America e arrivi in Portogallo, ad esempio. Sei chiamato a sfide da vincere ogni volta che inizi. Impari a districarti tra la meteorologia, la ricerca del limite della barca, devi ottimizzare le risorse, sapere quanta energia produci. La sfida è il modo migliore per conoscere le nostre menti e i nostri corpi e il dolore è solo un promemoria degli ostacoli che superiamo. E poi, la magia romantica della luna che sale, le stelle cadenti senza lo schermo dell’inquinamento luminoso, gli Albatros, lo spostarsi con la sola forza del vento, a volte evitando l’immondizia che purtroppo è presente nel mare, che stiamo rovinando».
La Globe 40
Giungiamo alla sua ultima fatica: la Globe 40.
Il Gryphon Solo2
«Una gara per Class 40, la mia preferita, cioè per barche di quaranta piedi, equivalenti a dodici metri. È una regata estrema, nel senso che, ad esempio, non ci sono riscaldamento e acqua, per alleggerire il mezzo. Un annuncio avverte che Joe Harris, per me “Giuseppe”, cerca un co-skipper. Partecipo alla selezione e mi sceglie. Svolgiamo una preparazione minuziosa, un training di sopravvivenza che consiste nell’imparare a lanciare razzi, a utilizzare la scialuppa di salvataggio e dispositivi medici. D’altra parte, si tratta di attraversare l’Atlantico del Nord, che si caratterizza per continue tempeste e percorriamo luoghi in cui non esistono soccorsi, con una velocità fino a 26.9 nodi, circa 50 chilometri orari. Da Lorient, in Francia, in otto tappe (Tangeri, Capo Verde, Mauritius, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, il mitico e cupo Capo Horn, Recife, Grenada) per tornare a Lorient nove mesi dopo».
Nove mesi soltanto in due sono lunghi, immagino. Come descriverebbe una giornata tipo?
4kg di mocetta tra le scorte di Junet
«Sono lunghi, ma se ci penso mi sembra che siano passati velocemente. Vivo di questa apparente contraddizione, oltre che del Post Traumatic Stress. Facevamo turni di tre ore per consentire all’altro di riposare. Nel tempo passato insieme analizzavamo il percorso, il meteo presente e previsto, gli avversari. Gli arrivi delle tappe ci consentivano uno stop allo stare sempre da soli. La vita è in un’altra dimensione, come nello spazio. Mangiavamo cibo liofilizzato – anche se avevo portato a bordo quattro chili di mocetta! – e sapevamo di dipendere del tutto dalla barca, per produrre energia e acqua. Due computer e due telefoni satellitari erano il nostro collegamento col mondo».
Quando svolgeva i turni da solo, quali pensieri attraversavano la sua mente?
«Dipendeva da dove eravamo, dalle condizioni meteo e dalle previsioni. In realtà, difficilmente c’era tempo per pensare, tra l’aggiustare la regolazione delle vele, guardare il radar e pensare a come far andare più veloce la vela».
Ha provato il sentimento della paura?
«Si tocca il Punto Nemo, nel Pacifico, cioè il punto più distante da tutte le terre del mondo, il luogo dove fanno cadere i satelliti, per intenderci, non ci sono neppure rotte commerciali. Le dirò una cosa: la paura, per me, è una buona compagna di viaggio, perché non ti fa prendere rischi che potrebbero anche essere letali. Certo, ciò che ti fa pensare è il commitment, cioè la consapevolezza che non puoi tornare sui tuoi passi, come se fossi in automobile, perché il vento non te lo consente. Devi procedere e basta».
Finalmente, dopo nove mesi, il ritorno a Lorient. La prima emozione?
Joe Harris e Roger Junet a Lorient, la conclusione della Globe 40
«Sollievo. Ripensavo ai pericoli che avevo corso, dosi di rischio alte, onde di dieci metri, la barca che si muove come in un ascensore, in alto e poi in basso, in una ripetizione senza fine. Ripensavo a quando non c’erano vie di fuga. E concludevo che, curiosamente, avevo più paura prima di partire che poi. Ed è stato stupendo vedere la mia famiglia e i miei amici venire incontro per festeggiarmi».
È contento del risultato ottenuto, tenendo conto che, anche nelle competizioni velistiche, il mezzo fa la differenza?
«Gli equipaggi iscritti erano quindici, siamo partiti in sette e abbiamo, Joe e io, chiuso quarti. Con la chicca di un secondo posto di tappa, diventato terzo a causa di una penalizzazione. Forse potevamo osare di più, spingere maggiormente in certi tratti, ma direi che va bene così. Anche perché, effettivamente, la nostra barca era più datata di altre».
Il futuro
Programmi, nell’immediato?
«La Normandy Channel Race, una regata, sempre per Class 40. Sei giorni da Caen all’Irlanda e ritorno».
E il sogno nel cassetto?
«Il Giro del Mondo in solitaria, senza scalo. Giro che è riuscito a un centinaio di persone, non di più. C’è stata più gente nello spazio, per dare un’idea della prova».
(enrico formento dojot)